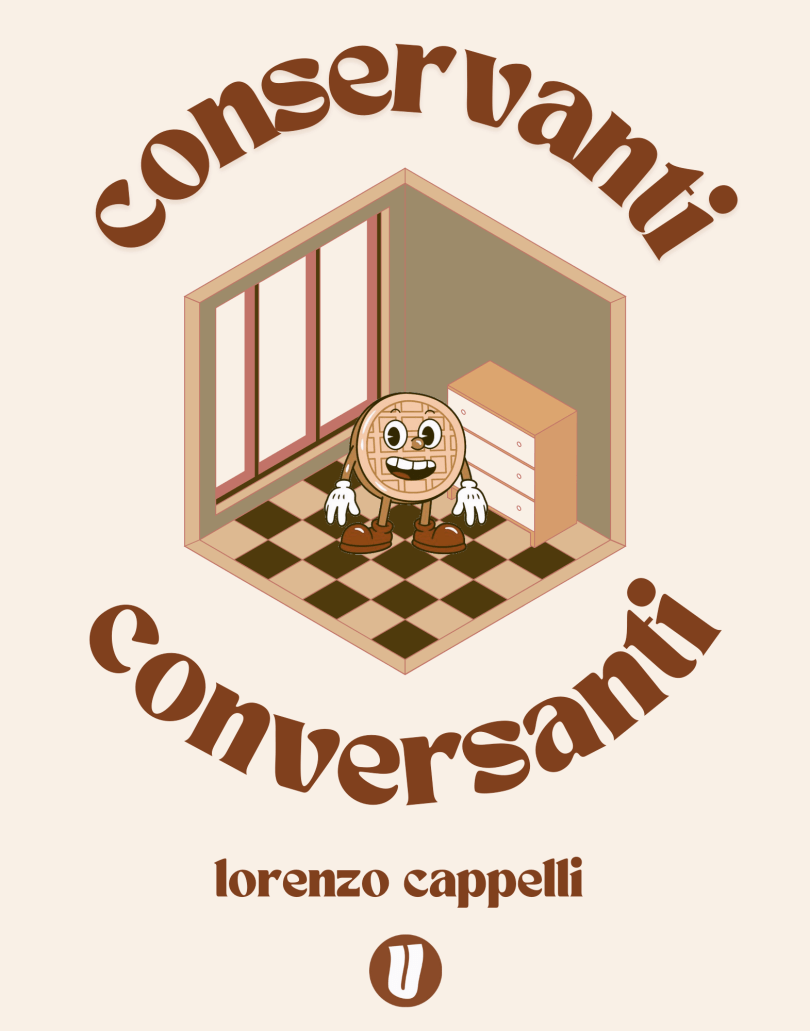«Basta con ’ste merendine!» mi rimproverava sempre mia madre. «Se continui così ne diventi una». O ancora: «Ma lo sai quante schifezze ci stanno dentro? Ma lo sai?»
No, in realtà. Intuivo che le merendine facessero male, o almeno non bene, però avevo appena iniziato le scuole elementari e non potevo trattenermi soltanto perché me lo diceva lei. Così ne mangiavo una, e un’altra, e un’altra ancora, e così via per il resto della giornata.
Nel giro di trent’anni le ho provate tutte. Iniziai con le Campanelle – dall’aspetto non mi convincevano, con quella granella così simile alla terra, poi mi piacquero così tanto che volevo ingoiarmi pure quella vera, di terra; proseguii con Biricche, Dondoli, Trottoline, Urrà, Yo-Yo, Girelle, Soldini. Ah, i Soldini degli anni Ottanta! Che dolci ricordi… Quando tornavo da scuola ne mangiavo dieci di fila: un po’ per gioco, un po’ perché avevo la scusa di abbuffarmi, cercavo ogni volta di finire il pandispagna senza staccare o spezzare la moneta di cioccolato che c’era sopra, con l’unico risultato di sporcare le mani, la bocca e a volte anche il divano (o il banco di scuola, se non riuscivo ad aspettare); o addirittura di ricoprirmi tutto il corpo con quella poltiglia, neanche fossi una merendina gigantesca e ipercalorica, ma almeno biologica.
E mia madre? Protestava, ovviamente, ma me le comprava lo stesso. «Questo è l’ultimo!» diceva al supermercato mentre buttava l’ennesimo pacco nel carrello. Sì, come no. Se continuava a prenderli era per risollevarmi il morale, perché un bambino non supera facilmente la morte del padre. Precipitato in un miscelatore industriale quando avevo sei anni. Allora mamma ragionava così: tanto vale distruggere la salute fisica del figlio per migliorare quella psicologica, no? Anche lei avrebbe dovuto provare la “cura delle merendine”.
Durante le scuole medie e superiori, continuai a mangiare merendine come se non ci fosse un domani, ma con prudenza: i miei compagni di classe erano falsi fino al midollo, pronti a offendere il grassone che si ingozza di porcherie per sentirsi fighi, parte del gruppo o robe del genere. Perciò le nascondevo nello zaino e le mangiavo in bagno con la puzza di merda, piscio e canne in sottofondo, oppure direttamente a casa (dove recuperavo gli arretrati con terribili mal di pancia). Avevo un detto, all’epoca: Crostatine a scuola, ciao ciao alla gola. Si sbriciolavano così tanto sotto il peso dei libri che avrei fatto prima a sniffarle.
Al terzo anno delle superiori mi innamorai di una ragazza, una di quelle bionde fissate con le calorie e le creme per il viso; ma quando eravamo nel corridoio durante l’intervallo e io, timidamente, provai a baciarla, lei si ritrasse disgustata. «Il tuo alito sa di cadavere.» Risposi che quella mattina avevo mangiato quindici Fiesta invece di venti (se non venticinque) proprio per baciarla con la bocca pulita, e lei di tutta risposta girò i tacchi e se ne andò. Non ci avrei più parlato – non che la cosa mi rattristasse: come potevo frequentare una ragazza che smorzava le mie passioni? Per consolarmi, tornai a casa e me ne mangiai trenta, di Fiesta.
Al contrario di quella saputella, le merendine non mi avrebbero mai abbandonato. Ma quella visione… Oh, sì… quanto avrei voluto leccarle il corpo ricoperto di crema e cioccolato…
Finita la scuola, valutai di iscrivermi all’università, e in particolare a un corso chiamato “Scienze delle merendine”, ma quando scoprii che con le merendine non c’entrava nulla lasciai perdere. Così cercai lavoro – mia madre non mi avrebbe offerto più un centesimo, e io dovevo comprare le merendine classiche e quelle moderne che si affacciavano sul mercato. La scuola di quartiere mi assunse come bidello, finché, beccandomi in flagrante mentre rubavo Flauti e Saccottini agli studenti, non mi licenziò; provai a fare il becchino, ma quando il capo scoprì che lasciavo cadere molliche di pandispagna e cioccolato nelle tombe ancora aperte – profanavo i cadaveri, a sua detta – mi licenziarono un’altra volta; infine diventai uno scaffalista e imballatore. L’ennesimo impiego solitario in cui potevo abbuffarmi di nascosto.
Poi, mentre ero in magazzino, uno scatolone pieno di olio di semi di girasole sotto il braccio sinistro e un Buondì nella mano destra, ebbi un malore. Caddi a terra e ci rimasi per un bel pezzo, stando ai colleghi. «Non sarà mica per tutte le merendine che ti mangi?» dissero al mio risveglio – sì, avevano smascherato la mia dipendenza già il primo giorno. Mamma era d’accordo. «Te l’avevo detto!» sbraitò quando lo scoprì. «Se ripenso a tutti i soldi che ho buttato…»
E ora toccava a me spenderne altrettanti: non in merendine – non soltanto, almeno –, ma in visite mediche, diete personalizzate, gastroscopie. Disprezzavo l’idea, perché avrei preferito spendere quei soldi diversamente – “Cento euro equivalgono a duecentottantuno Cornetti”, ragionavo tra me e me, “Duecento euro equivalgono a cinquecentodiciannove Mix Max”; comunque, se guarire mi avrebbe permesso di continuare a mangiare quelle prelibatezze… allora ero disposto a pagarne il prezzo, fisicamente e psicologicamente.
Be’, mi sbagliavo di grosso. Il medico mi disse che avrei dovuto smetterla con quelle robacce industriali, se ci tenevo alla pelle. «Ma lo sai quante schifezze ci stanno dentro? Ma lo sai?» Siccome i discorsi più tecnici non attecchivano, si era aperto in una grottesca imitazione di mia madre. «Dolcificanti, coloranti, conservanti, additivi.»
«Certo» risposi. «Le merendine sono dolci, colorate, conservate gelosamente nello stomaco del sottoscritto… e si addizionano, quando le mangio.»
«Almeno li leggi gli ingredienti sui pacchi? Hai avuto più di un’occasione per farlo. Prendiamo i conservanti: sostanze chimiche per preservare un alimento che, scadente com’è, marcirebbe in un paio di giorni.»
«Una roba inutile, tanto le merendine le mangio subito. Se rimangono nell’involucro troppo a lungo soffrono di claustrofobia.»
Il medico scosse la testa. «Inoltre…» Aprì il cassetto della scrivania, estrasse un foglio e lo poggiò davanti ai miei occhi, «c’è una cosa che voglio mostrarti.»
Era un documento scritto a mano, ingiallito in più punti. Come il tema libero che avevo scritto alle elementari: un calcolo dell’area geometrica applicato alle merendine – cerchio per le Biricche, quadrato per i Soldini e rettangolo per gli Urrà.
Quant’ero brillante, all’epoca!
«Tua madre mi ha detto di non parlartene» iniziò, «ma io lo faccio lo stesso, perché la medicina viene prima di tutto. Non ti sei accorto che non avrei dovuto sapere della tua dipendenza da merendine? Oh, certo che no, col cervello pieno di conservanti che ti ritrovi. Andiamo al sodo.» Indicò il documento. «Questo, come vedi, è un referto di tuo padre.»
Padre? Madre? Dipendenza da merendine? La medicina viene prima di tutto? Non ci capivo niente, l’unica cosa che desideravo in quel momento era una Brioss (possibilmente al cacao).
«Leggi.»
E va bene. Districandomi nella calligrafia sbilenca tipica dei medici, spizzicai qualche parola qua e là: volvolo gastrico; diverticolite; ipercolesterolemia; si consiglia… netto rifiuto del paziente; diabete mellito di tipo 2; carie ai denti. Poi… Ehi, aspetta un momento.
Girelle?
«Tuo padre era malato» disse il medico. «Sì, malato: proprio come te. Non riusciva a smettere di mangiare merendine, ecco cosa ha scritto in soldoni il mio vecchio – medico ben più qualificato di me. Credevo impossibile che girassero già negli anni Cinquanta, ma mi è bastata una breve ricerca per scoprire il contrario. Dopo un lungo, distruttivo rapporto con le merendine, tuo padre è giunto alla conclusione che le migliori fossero le Girelle. Guarda qui: “Sono spirali concentriche di frumento, cioccolato, uova e zucchero”» lesse dal referto capovolto, «“e il paziente ne mangia quattro pacchi al giorno, per un totale di trentadue porzioni”. Assurdo, le ho comprate proprio ieri a mia nipote. Un pacco soltanto. Una volta al mese, non di più. Non farti illusioni.» Si schiarì la voce. «Insomma, il tuo predecessore si abbuffava di quelle robacce nell’Italia del decollo industriale… E sappiamo entrambi com’è andata a finire, giusto?»
Giusto? No, io non sapevo niente. Eccetto che mia madre mi avesse mentito per tutto questo tempo.
Andai a trovarla quella sera stessa, la bocca piena di Bombolone e Trancino, e le chiesi perché raccontasse di anno in anno la storia del miscelatore. «Che alternative avevo?» fu la sua giustificazione. «Se non iniziavi da bambino con le merendine potevi farlo da adulto con canne, cocaina o chissà cos’altro. E poi… guardarti mangiare quelle schifezze mi ricordava lui.»
A malincuore, mi decisi: basta, basta con le merendine. Le amavo, ma volevo vivere – soprattutto per continuare a mangiarle. Come ragionamento non era il massimo, ma per iniziare andava benissimo.
«Ma lo sai quante schifezze ci stanno dentro? Ma lo sai?», mi tornarono in mente le parole di mia madre (che ora erano anche del medico). Vent’anni dopo, finalmente lo sapevo: additivi, dolcificanti, coloranti e soprattutto conservanti. Tutti veleni che dovevo eliminare dalla mia dieta. Mi dissi di farlo gradualmente, eppure un taglio netto sarebbe stato meno doloroso – basti pensare a mio padre, morto dall’oggi al domani senza lasciare traccia nei miei ricordi.
Così, dopo una simbolica “ultima cena” a base di Girelle, frittata, stracchino, crema di nocciole e tofu – il tutto imbevuto di vino bianco –, abbandonai definitivamente la mia vita da merendinaio.
Per distrarmi, mi buttai con anima e corpo sul lavoro. Annotavo gli ordini sul taccuino, gestivo le spedizioni, etichettavo le merci e le imballavo, ripercorrendo lo “sbustamento compulsivo” della mia vita precedente. I colleghi si congratularono per l’impegno. «Ti meriti una medaglia» dicevano, ignari che in realtà io non cercassi riconoscimenti: volevo soltanto distrarmi dall’unico, pressante chiodo fisso. Accumulai così tanti soldi che avrei potuto comprare un Buondì dorato coi diamanti al posto della granella di zucchero.
Da quand’è che non mangiavo una merendina, ormai? Un giorno divenne una settimana, un mese, un semestre, infine un anno. Il trucco era semplice: non vederle affatto. Se comparivano sullo scaffale del supermercato, giravo dall’altra parte; se sul volantino, lo strappavo. Quelle nella dispensa le buttai tenendo gli occhi chiusi – l’abilità nel maneggiarle rimaneva eccome –, compresa la Colazione Più che trovai sotto al frigorifero. Chissà da quanto tempo se ne stava lì, a prendere polvere. Perché non era marcita? Conservanti, probabilmente. Soprattutto, pensavo a questo: l’invitante ripieno disegnato sui pacchi è sempre meno della realtà. Distoglievo lo sguardo perfino dalla tuta da imballatore, le cui strisce marroni e gialle ricordavano cioccolato più pandispagna.
Un po’ per il lavoro, un po’ per la dieta, interruppi la metamorfosi in Bombolone diventando magro come un chiodo. Uno spiffero d’aria bastava per farmi spiccare il volo. Se un ex compagno di classe mi avesse rivisto, sarebbe stato invidioso della pancia piatta e dei bicipiti. Chissà, forse perfino quella saputella mi avrebbe concesso una seconda occasione… ma ormai guardavo oltre.
L’unico effetto collaterale dell’astinenza erano gli incubi. Di notte sognavo una schiera di merendine sormontata da un Pan di Stelle bucherellato dai vermi; e quelle merendine mi parlavano, mi dicevano di rimanere “conservate” apposta per me, e di come io, ignorandole, offendessi non soltanto loro, ma anche la mia natura più autentica. «Siamo parte di te» sussurravano, gli strati dell’impasto che si muovevano come labbra. «Siamo parte di te, siamo parte di te… e tu sarai una di noi.»
Un vortice si apriva nel pavimento a scacchi così simile al Pan e Cioc, le risucchiava e risputava al loro posto una bara. Il coperchio si sollevava magicamente, rivelando un cadavere. Il cadavere di mio padre? Via via che mi avvicinavo, i lineamenti del volto apparivano sempre più chiari, più familiari, più miei. Una poltiglia a metà tra terra e cioccolato avvolgeva il corpo, due monete coprivano gli occhi. Sulla fronte c’era stampata la data di scadenza… ma prima che riuscissi a leggerla mi svegliavo ogni volta, paralizzato sotto le coperte.
In quei momenti volevo rivestirmi, raggiungere il primo supermercato aperto e comprare una tonnellata di merendine; comunque, mi bastava ripensare al discorso del medico per trattenermi.
Almeno fino al giorno della tragedia. Lavoravo così tanto che il magazzino crebbe di pari passo, diventando il più importante della regione. Iniziò a spedire prodotti alimentari di ogni tipo: pane, pasta, latte, uova, carne, pesce… e merendine. Uno sconfinato, sgargiante mucchio di merendine.
Trancini, Bomboloni, Saccottini, Flauti, Fiesta, Girelle; ma anche Yo-Yo, Urrà, Trottoline, Dondoli, Biricche e diavolerie americane mai viste prima. Perfino i Soldini! In voga negli anni Ottanta, erano tornati sul mercato in edizione limitata; ma limitata non sembrava affatto, vista la quantità.
Una sera mi attardai in magazzino – succedeva spesso: prima per distrarmi, poi per terminare i lavori che la mia nuova carica dirigenziale richiedeva – ed ero completamente solo. Nella penombra delle luci al neon, i Soldini brillavano, letteralmente: la nuova edizione utilizzava non bustine in plastica, bensì eleganti scatoline in metallo. Nuove erano anche le forme delle merendine – da quadrate a rettangolari – e le facce degli acquirenti stampate sulle confezioni, con tanto di citazioni personalizzate. “Viva gli anni Ottanta!” diceva la prima, “A mia mamma, che me li comprò per la prima volta trent’anni fa” diceva la seconda. Tutti elementi scelti durante l’acquisto, probabilmente. Sarebbe stato meraviglioso fare lo stesso con la mia, di faccia! E mettere la confezione in cucina come soprammobile, senza mai aprirla. Ma cosa scriverci?
Nulla, perché tanto avrei mangiato le merendine degli altri.
“No, no e no” mi imposi, la lingua che salivava. “Non voglio buttare tutti i miei sforzi.” Ma era ancora peggio buttare quel ben di Dio, e allora ripensai al gioco che facevo da bambino, quello in cui mangiavo il pandispagna senza staccare o spezzare la moneta al cioccolato; non c’era nulla di male nel rifarlo una volta, una soltanto, eh, proprio come ai bei vecchi tempi, eh eh, in fondo meritavo di spassarmela dopo tutti gli sforzi per il lavoro e la dieta, no?
Afferrai una scatolina. Tanta era la foga con cui addentai il Soldino che la moneta si spezzò al primo morso. Provai una seconda volta. E una terza. E una quarta.
E prima che me ne accorgessi persi il conto e la voglia di giocare e semplicemente continuai a ficcarmi quelle robacce in bocca finché non esaurii gli scatoloni e ogni dignità.
Due giorni dopo, al rientro dal fine settimana, i colleghi mi trovarono sdraiato sul pavimento, morto, ricoperto da scatoline metalliche e cioccolato. Ebbene sì, alla fine le merendine erano riuscite nella non difficile impresa di ammazzarmi.
Ora mi trovo nella bara, sepolto da uno strato di terra così simile alla superficie delle Campanelle; tuttavia, da un lato sono morto, mentre dall’altro non lo sono affatto.
Il cuore rimane fermo dalla tragedia, ma di giorno in giorno ho iniziato a pensare, parlare, perfino muovermi, con un po’ di sforzo – non che possa andare da alcuna parte. Qualcosa di invisibile e sfuggito all’autopsia rinnova magicamente la mia esistenza.
Difficile razionalizzare l’accaduto, senza le parole del medico: «Conservanti, sostanze chimiche per preservare un alimento che, scadente com’è, marcirebbe in un paio di giorni.» Attraverso le merendine ne ho ingeriti tantissimi, accumulandoli nel cervello, nei polmoni e negli altri organi, e ora mantengono il mio cadavere perfettamente conservato.
«Una roba inutile» avevo risposto, ma un’utilità ce l’hanno eccome: omaggiano il loro estimatore numero uno con questo piccolo regalo.
Che noia, però! Qui dentro non c’è molto da fare. Dopo un allenamento semestrale per le braccia, sono almeno riuscito a estrarre dalla tasca il taccuino delle spedizioni e scriverci sopra la mia storia.
Un’opportunità per la quale ringrazio i colleghi e la loro decisione di seppellirmi con la tuta da imballatore, onorificenza della mia dedizione sul lavoro. Hanno addirittura poggiato un medaglione in bronzo sopra la bara. «Ti meriti una medaglia», me lo dicevano sempre. Il risultato? Un ammasso di conservanti dentro un parallelepipedo rettangolo, con una moneta sopra di esso: no, non mi sorprenderei affatto se mi scambiassero per un enorme Soldino.
Ma il ringraziamento va esteso a mia madre. Acquirente della “scatolina” più costosa di sempre, è merito suo se sulla lapide, sotto la foto, la data di nascita e quella di morte compare la scritta “Te l’avevo detto”. Evviva, finalmente anch’io ho la mia personalissima edizione limitata!
Allora mamma aveva ragione, quando diceva che a forza di mangiare merendine ne sarei diventata una. Invece si sbagliava, oh, eccome se si sbagliava, ripetendomi quanto facessero male: chissà cosa ne penserebbe il medico? Se stai leggendo queste righe, sappi che dovresti comprare più Girelle a tua nipote.
E le sorprese non finiscono qui: ora posso parlare con mio padre!
«Chi muore si rivede» ha esordito, e da allora siamo grandi conversatori. Mi ha raccontato del primo Mottino, del decollo industriale, della fierezza che prova per i gusti del figlio e dei tentativi di evasione; a mia volta, gli ho descritto le merendine più recenti nei minimi particolari.
Il suo ultimo tentativo di evasione risale a quindici anni fa. Dopo un allenamento altrettanto longevo, mio padre aveva imparato a ruotare su sé stesso a una velocità supersonica. Così è diventato una trivella umana che ha perforato la tomba e incorporato strati su strati di legno, terra, pietra e ossa, fino a trasformarsi in un’enorme Girella; peccato che la spirale, raggrumata com’è, l’abbia bloccato in un punto casuale del cimitero – situato a pochi metri dalla mia tomba, guarda caso. E allora parliamo, parliamo e parliamo ancora, le gole atrofizzate.
Conservanti conversanti, ecco il nostro nome. Uno scioglilingua coi fiocchi! Anche se le merendine la sciolgono meglio… Che amarezza, non potrò mangiarle per il resto della mia non-morte. Quanto ancora rimarrò conservato? Ormai nutro un’unica speranza: che i vermi si sbrighino, e siano golosi come il sottoscritto.
Illustrazione di Feed Your Head
Lorenzo Cappelli, appassionato di letteratura e cinema horror, ha studiato Scienze della comunicazione all’università di Bologna, per poi specializzarsi in Editoria e scrittura a quella di Roma. Vive a Milano, dove svolge l’attività di editor per Mondadori.