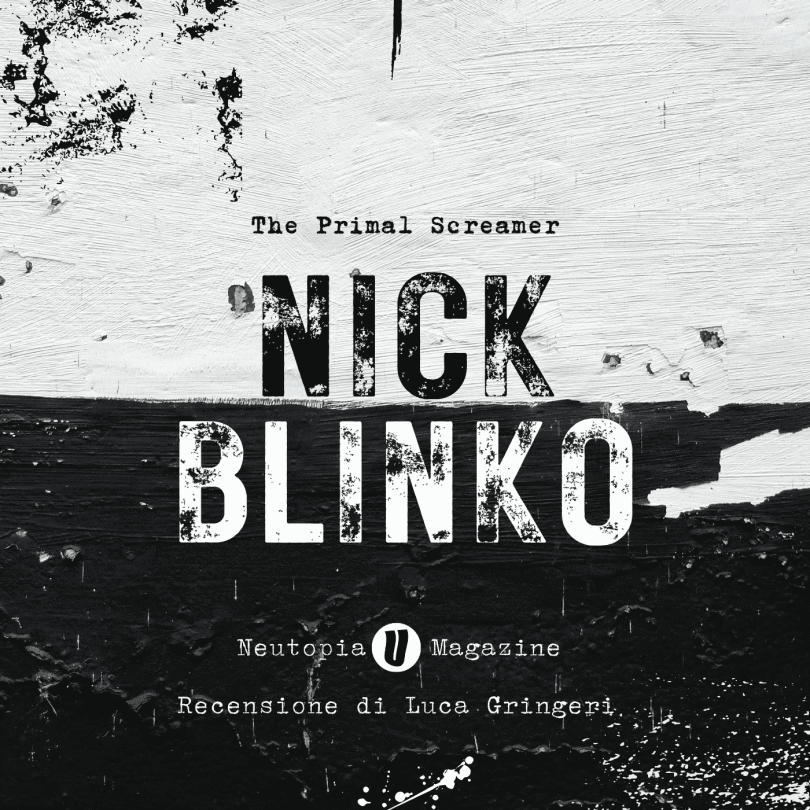UN PRINCIPIO DI TESTA CHE FA A MENO DEL PENSIERO
Quando ripenso alla prima volta che varcai la soglia di un CPS, il Centro Psicosociale di competenza territoriale che prende in carico le persone che soffrono di problematiche psichiatriche, mi torna in mente questo estratto da Infanzia di Arthur Rimbaud:
“Nel bosco c’è un uccello, il suo canto vi ferma e vi fa arrossire.
C’è un orologio che non suona.
C’è un burrone con un nido di bestie bianche.
C’è una cattedrale che scende e un lago che sale.
C’è una carrozzina abbandonata nel bosco ceduo, o che scende per il sentiero di corsa, infiocchettata.
C’è una compagnia di piccoli commedianti in costume, intravisti sulla strada attraverso il margine del bosco.
C’è infine, quando si ha fame e sete, qualcuno che ti scaccia”.
Il luogo era infatti erboso e verdeggiante, certo molto diverso da come ti aspetteresti un luogo pubblico che fornisce assistenza alle persone con disturbi della psiche. Ero lì per accompagnare un amico, già in trattamento da loro, e per sostenerlo nella sua decisione di non andare in comunità, come invece voleva il team che lo aveva in carico.
Entriamo, e l’atmosfera è più da ospizio che da “manicomio”, e dopo due battute con i gentili operatori ci accoglie la psicologa. Qui, posso notare tutte le fasi del conflitto fra una persona “sana” e una “insana”: quest’ultima comincia a dire le sue ragioni, sotto lo sguardo compassionevole della psicologa, che ribatte con un misto di infantilizzazione e linguaggio clinico; il mio amico si agita e comincia ad alzare i toni, mentre lo sguardo della terapeuta si fa sempre più freddo. Ghiaccio puro, dagli occhi e dalla bocca, con frasi che sono rasoiate: “Libero di non andare in comunità, ma scordati da oggi in poi la tua presa in carico da parte nostra. Arrivederci”.
Ora, non giudico, anche perché so per certo che i CPS vivono una grave crisi da quando i tagli alla spesa pubblica hanno colpito anche loro, e presumo che la scelta sia quella di tenere in cura gli “utenti” più collaborativi e allontanare chi è refrattario ai loro metodi. Farei lo stesso.
Eppure, quella frase del poeta francese mi rimbalza per la testa:
“C’è infine, quando si ha fame e sete, qualcuno che ti scaccia”.
In Storia della follia nell’età classica (1961) Michel Foucault ricostruisce la storia del modo in cui la società occidentale ha compreso e trattato la follia, intesa non come semplice malattia ma come costruzione culturale e sociale. Nel Medioevo, la follia era vista come qualcosa di misterioso e vicino al sacro, dotata persino di un valore simbolico o profetico. Con l’età classica, tra XVII e XVIII secolo, la nascente ragione moderna produce invece un processo di esclusione: la follia viene separata dalla ragione e i folli vengono internati insieme a poveri e devianti negli ospedali generali, in quella che Foucault chiama il “grande internamento”. Nell’Ottocento, con l’avvento della psichiatria, la follia viene medicalizzata e posta sotto il controllo del sapere scientifico, ma secondo Foucault questa nuova forma di sapere non libera il folle: semplicemente sostituisce alla violenza della reclusione il potere “razionale” del discorso medico.
Malgrado la situazione di “colpevolizzazione” della persona patologizzata sia molto migliorata, anche grazie alle teorie di Basaglia che in Italia hanno portato alla importante riforma del 1978, e alla chiusura definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari (sostituiti però dalle REMS), la condizione dello “psichiatrico” rimane una zona d’ombra all’interno della collettività. Nel mondo diviso in classi, infatti, la condizione sussume l’identità, e la diagnosi pare diventare il carattere univoco di una intera vita. Così è per un malato di cancro, per una persona con la sindrome di down, ma così è anche per un sottoproletario costretto dalle condizioni cui versa a delinquere oppure, in chiave “positiva”, per un manager “che si è fatto da solo”. Siamo una società che, nel suo antimarxismo, nega che la struttura produca la sovrastruttura, e al contempo leggiamo l’altro in base alla sua posizione socioeconomiche (poiché tutti sappiamo che anche le patologie fisiche e psichiche investono l’individuo di uno slittamento nel posizionamento sociale).

Ma è sempre così? Ecco, Nick Blinko nel suo romanzo The Primal Screamer, uscito nel 1993 e tradotto in italiano da Garganta Press solo questo ottobre, applica un rovesciamento di questa tendenza, risultando forse l’operazione più punk mai fatta in ambito psichiatrico.
Blinko, inglese classe 1961, è conosciuto ai più come il cantante e chitarrista dei Rudimentary Peni (“pene rudimentale” in goffo latinorum). I Peni erano uno di quei tanti gruppi che, all’inizio degli anni ’80, costituiva l’ossatura della scena anarchopunk. Capitanata dai Crass, questo movimento rifiutava il nichilismo di una parte del primo punk, e optava per un approccio consapevole, politicamente impegnatissimo e militante su tematiche quali l’anarchismo, il femminismo, l’antispecismo e, in alcuni casi come Conflict o Hit Parade, la repressione.Musicalmente, tentava di distinguersi dalle band più stradaiole e anthemiche o con la velocità (Discharge), o con marcette semi-militaresche e rasoiate di feedback (Crass, Flux of Pink Indians), melodie anni 60 (Astronauts) o, infine, con un sound oscuro e disturbante.
Fra questi ultimi, trait d’union fra il punk/hardcore e la nascente musica goth, c’erano i Mob, i Blood & Roses e i Rudimentary Peni. Ma mentre i primi due erano “dark” per le influenze gotiche, i Peni lo erano per il senso quasi claustrofobico di follia cui ti precipitavano.
Dopo i primi due EP, feroci e schizzati, il debut “Death Church” ti mordeva alla gola con i cangianti vocalizzi di Blinko, le chitarre ribassate, il basso nitido pienamente postpunk e soprattutto testi come:
“Tre quarti del mondo stanno morendo di fame
Il resto è morto”.
Molto diverso dai sermoni dei Crass, o dalle invettive rivoluzionarie dei Conflict, e ancor di più lo dimostreranno con il loro secondo album, Cacophony (1988), completamente ispirato alle opere di Lovecraft a partire dalla copertina (disegnata, come ogni cosa, da Blinko) che ritrae un faustiano Erich Zann intento a suonare il suo violino.
Un disco fatto di una sequenza rapidissima di canzoni che vivono di cambiamenti schizofrenici, gorgoglii, borbottii, in uno dei migliori esempi di messa in musica della weirdness.
Weirdness che Nick, del resto, sperimenta anche nella vita quotidiana: fin da giovanissimo, infatti, egli soffre di disturbo schizoaffettivo, che comporta lunghi periodi di depressione con pensieri suicidari ed episodi maniacali e schizoidi in cui è vittima anche di allucinazioni, che riversa nei suoi disegni, nei suoi testi e nelle sue canzoni.
Così è nel caso del terzo album, Pope Adrian 37th, composto nel ’92 in un ospedale psichiatrico cui era stato internato a causa della sua improvvisa convinzione di essere Papa Adriano 37esimo. Potrebbe far scappare un sorriso questa storia, non fosse che l’album in questione, pubblicato tre anni più tardi, è la messa in musica di un episodio psicotico. Ogni canzone, infatti, ripete come un mantra il titolo del pezzo, e nei rari casi in cui Blinko si impegna a scrivere almeno una strofa escono fuori cose del genere:
“è un vero peccato che il papa senza nome non sappia come si chiama chiusura confusione è così triste, deliri di grandezza deve essere pazza un giorno la mia testa crescerà fino a diventare una possente cupola papale mi sveglierò vecchio uomo mitra uomo mitra.”
(The Pope with No Name)
Proprio in questo periodo di fissazione papale, il mondo si accorge di Blinko: una mostra alla National Schizophrenia Fellowship nel 1994 porta per la prima volta la sua arte all’attenzione del grande pubblico e della critica, che lo afferma come esponente di rilievo dell’”arte outsider”, e ora è esposto nella Collection de l’art brut di Losanna; l’anno successivo, pubblica The Primal Screamer, che vivrà un grande successo in Inghilterra con tre ristampe in pochissimi anni.
Il romanzo ci accoglie con in copertina una storica illustrazione di Blinko, tratta dal primo EP dei Rudimentary Peni, che mostra un mostruoso feto scheletrico. Sfogliando le pagine, ne troveremo altre, a prima vista fuoi contesto ma in verità incastonate nel significato nascosto fra le pieghe del libro.
Scopriamo quindi la storia di Nathaniel Snoxell, un giovane con tendenze suicide, dalla penna del suo terapeuta, Nathaniel H. Dweller. Lo psichiatra, violinista per passione (e il riferimento a Erich Zann è solo uno dei tanti tributi a Lovecraft del romanzo), racconta sul suo diario i progressi di cinque anni di terapia, dal 1979 al 1984, del giovane Snoxell, che da misantropo anedonico diventa poi cantante e chitarrista di una band anarchopunk.
Mentre il giovane riesce a fare delle sue visioni di morte un’arma, piano piano lo psichiatra scivola in incubi sempre più orribili, fino ad arrivare a un transfer quasi completo col suo paziente.
Vi sono echi di una lunga narrativa di scambio fra “sano” e “insano”, da Il Metodo del Professor Piuma e del Dottor Catrame di Edgar Allan Poe a La Corsia Numero 6 di Anton Cechov, ma qui l’esperienza è ancora più shockante: se nel racconto di Poe i pazienti prendono il controllo del manicomio e si fingono dottori, mentre il cupo rapporto fra medico e paziente del racconto di Cechov è una riflessione, molto avanti sui tempi, sulle strutture di internamento, con Blinko andiamo a toccare il nucleo della follia.
Essa è come una divinità abissale più antica del mondo, che sceglie i suoi emissari per schiudersi nel cervello di ognuno. Il Nathaniel paziente scopre come utilizzare questio Dio grottesco, questo “urlo originario”, nelle proprie opere, mentre il represso Nathaniel psichiatra ne viene avvinto facendo crollare tutto il suo mondo fatto di ordine. In un magnifico esperimento meta-letterario, di pagina in pagina sprofondiamo sempre più nel delirio insieme al dottore, quando nelle prime pagine era tutto ferrea logica e humour inglese.
Cosa vuole dirci Blinko? Che in fondo la sua follia è la follia di tutti? Forse. Del resto, un altro grande musicista psichiatrizzato, Roky Erickson, cantava “Io penso ai demoni per voi”, rivendicando la “follia” come l’emersione di quel segreto inconscio occultato nel profondo di noi tutti.
Ma Blinko, ancor di più, sembra ricalcare il motto del SPK, il Collettivo dei Pazienti Socialisti che nella Germania di inizio anni 70 aveva messo in discussione l’intera istituzione psichiatrica: “Fare della malattia un’arma”. Del resto, nel loro documento programmatico, i membri del SPK, pazienti e psichiatri, scrivevano al punto 11: “La salute è una chimera biologistico-nazista che ha la funzione di dissimulare, nella mente di tutti gli ingannatori e di tutti gli ingannati di questa terra il fatto che la malattia è condizionata socialmente, nonché di dissimulare la funzione sociale della malattia”, e Blinko tramuta questo enunciato in un romanzo. La malattia “primodiale” cui è affetto Nathaniel non è poi così diversa dalla desolazione dell’Inghilterra thatcheriana cui è immerso, la terapia è pura formalità fatta per credere che vi sia un ordine del mondo, ma soprattutto la pazzia può diventare atto creatore che scuote le fondamenta spettrali del sistema.
Non parliamo strettamente di antipsichiatria anarchica, poiché Blinko non attacca frontalmente l’istituzione psichiatrica, quanto piuttosto ne disvela il suo carattere di feticcio.
Cacciato dal CPS, il mio amico si guarda attorno spaesato. “Ho perso anche questo” mi fa, sconsolato. Non so cosa dirgli, e in silenzio ci lasciamo la struttura alle spalle. Sono passati anni, non è mai andato in comunità, ma non è stato neanche più ricoverato e ha avviato un processo di autonomizzazione, sempre seguito da uno psicologo, che gli ha permesso di vivere senza terapie farmacologiche (se non al bisogno, fra droghe e farmaci).
L’istituzione totale non è il destino manifesto di ogni persona psichiatrica e, come scriveva Antonin Artaud sui suoi quaderni dal manicomio, nel romanzo di Blinko come nella storia del mio amico io ci vedo:
“un inizio di testa che finalmente
fa a meno del pensiero
e vive non di sola civiltà,
ma anche di giunture che sono dei pieni,
cioè qualcosa che si piega,
che sento adattarsi alla mia volontà,
pur non muovendomi affatto dal mio corpo,
e che nessuno può determinare
né togliermi,
neanche a costo della verità”.
PLAYLIST
Rudimentary Peni – Gentlemen Prefers Blood
Part1 – Graveyard Song
Roky Erickson – I Think of Demons
Rudimentary Peni – The Pope with No Name
SPK – Slogun
The Mob – The Mirror Breaks
Rudimentary Peni – Pachebel Canon in E
Xiu Xiu feat. Michael Gira – Under Pressure
Nick Blinko è un artista, musicista e scrittore inglese nato nel 1961. Dai primi anni ’80 è chitarrista e cantante dei Rudimentary Peni, band che gode di fama internazionale nei circoli punk e d’avanguardia, dopo avere pubblicato dischi come Death Church (Corpus Christi Records, 1983) e Cacophony (Outer Himalayan, 1988), considerati veri classici del genere. Blinko, a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoaffettivo all’età di diciassette anni, rappresenta una figura leggendaria dell’outsider art, e ha esposto i suoi dipinti e disegni in gallerie di tutto il mondo. Alcune opere sono parte della Collection de l’Art Brut di Losanna. Vive ad Abbots Langley, nell’Hertfordshire, Regno Unito, dove continua a scrivere, dipingere, e registrare musica. Tra i suoi libri: The Primal Screamer (Spare Change, 1995), The Haunted Head (Coptic Cat, 2009), Visions of Pope Adrian 37th (Coptic Cat, 2011), Nick Blinko (Zagava Books, 2020). Il suo racconto, Punk Alice, è stato incluso nell’antologia Gobbing, Pogoing and Gratuitous Bad Language!: An Anthology of Punk Short Stories (Spare Change Books, 1996) curata da Stewart Home.